La Chiesa di Santa Maria della Passione è una delle più grandi e significative chiese di Milano, conosciuta per la sua maestosità architettonica e il suo ricco patrimonio artistico. Situata in via Conservatorio, vicino al Conservatorio di Milano, questa chiesa rappresenta un importante esempio di architettura rinascimentale e barocca.
La Chiesa di Santa Maria della Passione ha svolto un ruolo importante nella vita religiosa e culturale di Milano per secoli. Come sede dei Canonici Regolari Lateranensi, fu un centro di attività religiosa, educativa e artistica. La vicinanza al Conservatorio di Milano ha rafforzato il legame della chiesa con la musica e l’arte.
Oggi, la chiesa continua a essere un importante luogo di culto e un punto di riferimento per la comunità milanese. È anche una meta turistica e culturale, attratta dalla sua bellezza architettonica e dalle sue opere d’arte. Concerti d’organo e altri eventi culturali vengono spesso organizzati nella chiesa, sottolineando il suo continuo legame con la musica e le arti.
La Chiesa di Santa Maria della Passione rappresenta una testimonianza vivida della ricchezza storica, artistica e spirituale di Milano, unendo elementi rinascimentali e barocchi in una sintesi armoniosa e affascinante.
Per maggiori informazioni clicca sulle date delle iniziative in programma nel comune di

La chiesa fu fondata nel 1486 per volontà dei Canonici Regolari Lateranensi, un ordine religioso che aveva ricevuto il permesso di edificare un nuovo luogo di culto dedicato alla Vergine Maria. La costruzione della chiesa iniziò alla fine del XV secolo e si protrasse per diversi decenni. Originariamente progettata in stile gotico, la chiesa fu completata in stile rinascimentale.
L’architetto principale del progetto iniziale fu Giovanni Antonio Amadeo, che lavorò anche al celebre Duomo di Milano. La chiesa di Santa Maria della Passione presenta una pianta a croce latina con tre navate e un’imponente cupola centrale. L’architettura riflette le influenze del Rinascimento lombardo, caratterizzata da linee pulite, proporzioni armoniose e una ricca decorazione scultorea.
Nel XVII secolo, la chiesa subì importanti trasformazioni in stile barocco. L’interno fu decorato con affreschi, stucchi e altari sontuosi. Tra gli artisti che contribuirono alla decorazione barocca della chiesa ci sono Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, e Daniele Crespi. Le cappelle laterali furono arricchite con opere d’arte che riflettevano il gusto barocco per il dramma e il movimento.
La facciata attuale della chiesa fu completata nel 1729 su progetto di Giovanni Battista Quadrio. Questa facciata in stile barocco tardivo presenta elementi neoclassici, con colonne corinzie, frontoni e una ricca decorazione scultorea. La facciata è considerata uno degli esempi più significativi dell’architettura neoclassica milanese.

Nei dintorni

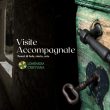

 Via A. Kramer, 5, Milano, MI, Italia
Via A. Kramer, 5, Milano, MI, Italia







