La chiesa, orientata a nord-ovest, è costituita da un piccolo edificio rettangolare caratterizzato da una facciata a capanna interamente intonacata con zoccolatura in lastre lapidee a spacco, conclusa con un timpano triangolare e preceduta da un piccolo sagrato quadrangolare. Al centro della facciata si apre l’ingresso principale alla chiesa, costituito da un portale lapideo architravato con un portone ligneo a due battenti, coperto da una lastra lapidea modanata a sorta di protiro, sorretta da due mensole curvilinee dotate di gocce classicheggianti. Sopra ad esso è conservata una riquadratura in leggero sotto squadro monocroma. La facciata risulta inquadrata da un’incorniciatura leggermente aggettante e sormontata da una piccola croce metallica infissa in un basamento lapideo troncoconico.
Internamente la chiesa è ad aula coperta da una volta a botte a sesto ribassato. L’area per i fedeli è separata dal presbiterio attraverso una balaustra marmorea, suddivisione sottolineata anche dall’arco trionfale impostato su due colonne ioniche dotate di un imponente basamento e dalla differenza di quota, risolta con tre alzate.
L’altare si presenta con una rigorosa struttura geometrica in marmi policromi, con una mensa dal fronte decorato con citazioni bibliche e, al centro, la custodia eucaristica ornata dalla raffigurazione dell’Agnus Dei.
Sulla parete di fondo del presbiterio, inquadrato da una struttura architettonica mistilinea dotata di colonne corinzie, l’altorilievo eseguito nel 1814 dallo scultore Giuseppe Fabris raffigurante la Madonna Addolorata. La chiesa è illuminata da due monofore per lato e da due finestre termali nel presbiterio, tutte decorate con vetrate artistiche. Alle pareti della chiesa sono murate sette lapidi sepolcrali di dimensione eterogenea appartenenti alle famiglie Mellerio, Cavazzi della Somaglia e Castelbarco, e alcune targhe commemorative di fattura moderna.
L’edificio conserva anche di una cripta funeraria nelle quali sono ancora oggi parzialmente riposte le spoglie del conte Giacomo Mellerio e di alcuni componenti della sua famiglia, il cui accesso è occluso dalla lapide pavimentale posta al centro della piccola aula dei fedeli.

1801 – La struttura della chiesa della Beata Vergine Maria Addolorata risale al 1801 quando la famiglia Cavazzi della Somaglia, proprietaria dei terreni e degli edifici limitrofi, decise di ricostruire un piccolo edificio di culto da trasformare in cappella funeraria di famiglia.
1815 – La chiesa fu aperta al culto nel 1815 alla presenza del cardinale Lorenzo Litta Visconti Arese.
1817 – A partire dal 1817 la custodia della chiesa, ancora sussidiaria della chiesa parrocchiale eretta all’interno della soppressa Certosa di Garegnano, fu affidata ad un cappellano che risiedeva in alcuni locali attigui all’oratorio sempre di proprietà della famiglia Cavazzi della Somaglia.
1896 – Particolarmente viva fu l’influenza di questo santuario nei confronti della chiesa della Cagnola, il cui parroco, don Francesco Ongania, nel 1896 istituì la Pia Unione della Vergine dei Dolori. Denominato anche Oratorio della Colombara, la chiesa della Beata Vergine Maria Addolorata poté conservare il Santissimo Sacramento solamente a partire dal 1908. L’evento fu festeggiato solennemente il 9 febbraio di quell’anno, quando si volle solennemente festeggiare la concessione arcivescovile. Il santuario dell’Addolorata, infatti, non costituiva chiesa autonoma, ma era sussidiaria della parrocchia di Garegnano, sorta, a sua volta, nel territorio dell’antico monastero della Certosa di Milano.
1921 – L’originario edificio ottocentesco venne “restaurato” nel 1921.
1927 – Nel 1927 il cardinale Eugenio Tosi autorizzò l’inserimento in chiesa di una Via Crucis.
1945 – Nel dopoguerra la famiglia Cavazzi della Somaglia, che aveva ereditato i possedimenti del conte Giacomo Mellerio, decise di intraprendere un’operazione di vendita del proprio patrimonio immobiliare e di cedere i terreni agricoli situati nel territorio di Boldinasco, della Colombara e della Comina, sul quale negli anni successivi fu edificato il quartiere Gallaratese. La famiglia Gavazzi decise anche di donare il santuario alla curia diocesana insieme ad una porzione di terreno per l’eventuale costruzione di una chiesa nuova. Come controparte la curia si impegnava a provvedere alla manutenzione dell’antica chiesetta ottocentesca.
1951 – Nel 1951 il cardinale Ildefonso Schuster concesse il permesso di dotare la chiesa di una nuova campana benedetta da monsignor Giulio Marchiandi e realizzata dalla fonderia Fratelli Barigozzi impiegando materiali di recupero donati dal Ministero dei Trasporti.
1960 – L’oratorio privato della famiglia Cavazzi della Somaglia, fino ad allora sussidiaria della limitrofa parrocchia di Santa Maria Assunta in Certosa, divenne chiesa parrocchiale con decreto arcivescovile del 21 settembre del 1960 che stralciò alcuni aree pastorali in precedenza appartenenti alle parrocchie di Santa Maria Assunta in Certosa, Santa Marcellina e San Giuseppe.
1960 – Intorno alla metà degli anni sessanta accanto al piccolo santuario urbano venne edificato il nuovo edificio di culto, decretando un cambio di fruizione liturgica dell’antica struttura che condusse anche ad un periodo di ‘abbandono’ della chiesa.
2001 – Dopo un periodo di abbandono, il santuario è stato ripristinato al culto oratoriale e sono stati intrapresi lavori di restauro e manutenzioni che hanno riguardato anche il rifacimento delle coperture, la pulitura delle lapidi commemorative e funerarie, il restauro dell’opera scultorea di Giuseppe Fabris e la sistemazione del piccolo campanile.
2001 – Il 2 settembre fu benedetta nuovamente la chiesa alla presenza di monsignor De Scalzi.
2010 – Il 26 settembre, in occasione della festa dell’Addolorata alla Colombara, mons. Giampiero Crippa benedisse le nuove vetrate artistiche policrome.

Nei dintorni
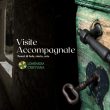

 Milano
Milano

