Santa Maria Podone chiude il lato settentrionale della piazza Borromeo con il suo prospetto composito.
Il pronao classicheggiante al centro della facciata, giustapposto alla basilica di antiche origini nel primo Seicento, infatti, contrasta con l’allungata mole quattrocentesca in laterizio della cappella gentilizia dei Borromeo, ornata di pinnacoli, che si sviluppa in appendice al corpo della chiesa.
A destra dell’ingresso s’innalza la statua seicentesca di san Carlo, ritagliata “sullo sfondo rosso acceso della cappella” (Bascapè-Mezzanotte) e qui trasportata dal Cordusio nel corso del tempo.
La piazza, la chiesa e parte degli edifici che fanno corona allo slargo costituiscono i tasselli di una storia di famiglia, quella dei Borromeo, che nella ricostruzione della chiesa e del fronteggiante palazzo affidarono, soprattutto grazie alla figura di Vitaliano I, l’avvio di crescenti fortune.
Il quadro urbanistico complessivo assunse nei secoli il delicato equilibrio fissato nella stagione del vedutismo ottocentesco (Inganni) e nelle parole di Giacomo Bascapè e Paolo Mezzanotte: “uno dei pochi angoli superstiti della vecchia Milano, ove sembrava che il corso del tempo si fosse fermato, fra le antiche architetture e le memorie di un grande passato.
Una fila di pilastrini e un gruppo di tigli ne aumentavano il raccoglimento”. L’edificio sacro, come anticipato, precede l’avvento dei Borromeo perché voluto nell’871 da tal Verulfo detto “Podone”, donde l’appellativo. Le più antiche fasi non sono riemerse neppure durante i recenti restauri (2004-2005), che pure hanno restituito leggibilità alla stagione romanica, quando la basilica fu rifondata, come è oggi, in tre navate.
Su questo schema fu innestata la trasformazione promossa da Vitaliano dal 1440.
Il tutto subì una radicale riconfigurazione per volere del card. Federico Borromeo e sotto la direzione di Fabio Mengone. Pertanto, facciata e corpo della chiesa presentano in maggiore evidenza i caratteri di un classicismo espresso in ordini e decorazioni sovradimensionate, a partire dal prospetto. Questo si articola in un’unica campata conclusa da un timpano ad ali spezzate per recare in evidenza, al centro, lo stemma dei Borromeo.
La campitura è risolta ad arco trionfale serrato da lesene corinzie con pronao esastilo nel fornice centrale. Sopra la porta d’ingresso, un bassorilievo con Madonna e Gesù bambino affiancati da due offerenti (Giovanni e Vitaliano II Borromeo), opera del 1483, introduce all’interno.
Le tre navate, seppur d’antica fondazione, sono scandite da pilastrate doriche, così come fu praticato nel corso del XVII sec.
L’intervento seicentesco, tuttavia, non riuscì a modificare il passo alternato delle campate, impostato su due campate maggiori e due minori.
Lo schema derivava dalla necessità espressa nel XV sec. dai Borromeo di innestare, in corrispondenza della prima campata maggiore, due ampie cappelle laterali come spazio di celebrazione famigliare. La cappella destra è ancora leggibile nei caratteri quattrocenteschi: terminazione poligonale, pareti in cotto, finestre a sesto acuto, oculo centrale e volta a costoloni.
La cappella sinistra, del Crocifisso, è di più recente creazione.
I tre corridoi della basilica medievale si concludevano in absidi semicircolari con copertura a calotta, così come è stato possibile appurare durante i recenti restauri che hanno riportato in luce il catino settentrionale.
L’abside maggiore è stata ricostruita in curva durante il XVII sec., traslata dietro un profondo presbiterio rettangolare.
L’abside di destra, invece, è perduta. Da qui, comunque, è possibile accedere alla sacrestia dove è stato rimesso in luce un portale strombato, documento di maggior rilevanza della fabbrica romanica della chiesa, ed è stato restaurata la lunetta raffigurante la Madonna con Gesù bambino su fondo di pastiglia dorata.

Nei dintorni


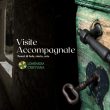
 Milano
Milano




