La Chiesa di Santa Maria Incoronata è un interessante edificio religioso situato nel centro di Milano, noto per la sua architettura unica e la sua storia affascinante. Questa chiesa è una testimonianza del passato rinascimentale della città ed è un luogo di grande interesse artistico e culturale.
E’ un esempio significativo dell’arte e dell’architettura rinascimentale a Milano. La sua storia è strettamente legata alla dinastia degli Sforza e alla loro ascesa al potere. Ancora oggi, la chiesa è un luogo di culto attivo e una meta per chi è interessato alla storia e all’arte.
La chiesa è aperta ai visitatori, che possono ammirare la sua architettura unica e le sue opere d’arte. È situata in una zona centrale di Milano, vicino a Corso Garibaldi, e rappresenta una tappa interessante per chi visita la città.
E’ un gioiello rinascimentale nel cuore di Milano. La sua storia, la sua architettura e le sue opere d’arte la rendono un luogo imperdibile per chiunque sia interessato alla cultura e alla storia della città. La doppia chiesa, in particolare, rappresenta una curiosità architettonica che testimonia il ricco passato di Milano.

La chiesa del Carmine nacque come “chiesa nobile” del castello, accanto alle vaste distese bastionate dove le milizie si addestravano alla guerra o a sanguinose battaglie. Non si fatica così a comprendere come il convento e la chiesa dei Carmelitani fossero così venuti a trovarsi coinvolti in un’opera di assistenza ed aiuto davvero singolari: ricovero di feriti, nascondiglio di sbandati, opera di pacificazione, di consiglio, di mediazione.
La chiesa del Carmine nacque dunque come chiesa aristocratica, viscontea nella prima e seconda versione, sforzesca nella terza edizione, quella definitiva anche se incompleta perché soggetta ad un crollo nel 1446.
Ricevette devozione, culto e onori da alcune tra le importanti famiglie milanesi. Fu tenuta in grande considerazione dai Visconti, tra i quali si ricordano: l’arcivescovo Giovanni, il duca Gian Galeazzo ed il duca Filippo Visconti.
Fu sostenuta e finanziata dagli Sforza, da Francesco Sforza, da Galeazzo Maria, dal cardinale Ascanio Sforza, da Gian Galeazzo Maria ed infine da Ludovico il Moro, e dai consiglieri, ciambellani e cavalieri, appartenenti – i più noti – alle famiglie Simonetta, da Corte e Lampugnani. Ed anche successivamente, la chiesa del Carmine fu cara a tanti nobili casati milanesi, via via legati ai successivi “padroni” francesi, spagnoli e austriaci.
A questa ricca frequentazione fin dal principio si affiancarono alcune confraternite, tra le quali – famosissima e potente – la “Scuola dell’Abito del Carmelo” che nel periodo più antico della chiesa contese (fino al 1391) il primato all’altra non meno fiorente “Arciconfraternita dei Divoti della Purificazione”. Questa confraternita trasse il nome del titolo che la chiesa, inizialmente dedicata all’Annunciazione, ebbe ad avere per qualche decennio prima di assumere definitivamente quello della Madonna del Carmine; dopo un periodo di decadenza, si ricostituì nel 1511, quando pose sede al Carmine presso la cappella della Purificazione.

Cosa vedere
Scopri le opere presenti presso Chiesa di Santa Maria del Carmine (Milano)


Nei dintorni


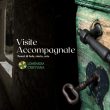



















 Milano
Milano




