S. Maria alla Porta prende nome dall’antica porta Vercellina, aperta nella più antica cerchia muraria della città lungo la strada Vercellese.
La chiesa è frutto della ricostruzione di un primo edificio di culto d’età romanica, già rimaneggiato nel XV sec. (addirittura, secondo tradizione, da Bramante), avviata alla metà del XVII sec. su disegno di Francesco Maria Richini. S. Maria alla Porta, anzi, fu l’ultimo progetto di Richini che, nato in questa parrocchia, morì prima di veder completata l’opera.
La facciata, anche se si deve all’intervento di Francesco Castelli, “è di forma tipicamente richiniana”.
Si presenta intessuta di decorazioni in forte aggetto, scandita in due ordini e “ricca di motivi architettonici, fantasiosamente vari, non già affastellati, ma governati, disciplinati” (Bascapè-Mezzanotte). Un insieme “di mirabile vaghezza”, secondo l’opinione espressa da Carlo Torre a lavori appena conclusi (1674).
L’ordine inferiore è scandito da due colonne e quattro pilastri con capitelli ionici, intervallati ai lati da due nicchie con santi, innalzati su alti piedistalli di granito rosa.
Al centro si apre un maestoso portale ornato da un altorilievo (‘Assunzione della Vergine’) di Carlo Simonetta (1670). L’ordine superiore, serrato tra due volute, è percorso da quattro colonne corinzi intervallate, ai lati, da due nicchie. Vi si apre il finestrone. Le numerose figure che popolano il prospetto (tra altri: i santi Luigi, Ambrogio e Carlo nelle nicchie superiori, gli angeli che svettano sopra il timpano e, nel timpano, ai lati di un orologio ottocentesco) sono opera di autori diversi tra il XIX e il XX sec.
L’interno è a una sola navata e termina nell’aula quadrata destinata a presbiterio e sormontata da una cupola.
Oltre, si sviluppa il coro ricostruito in profondità nel 1849.
Nei fianchi si susseguono le cappelle, aperte sulla navata centrale con slanciate serliane, sostenute da coppie di colonne di granito con capitello composito, e collegate senza soluzione di continuità così da creare corridoi laterali percorribili. Il motivo era stato introdotto nei primi pensieri di riforma elaborati da Francesco Maria Richini (1651-1652), quindi variamente ripreso durante i completamenti.
Le campate estreme della navata, all’ingresso e all’innesto del presbiterio, presentano un passo ridotto.
Tra le serliane si alternano nicchie rimaste vuote; la campata minore verso il presbiterio ospita un piano ammezzato affacciato alla nave con tribunette.
La navata è conclusa da una volta a botte innestata su un fregio a dentelli, marcata da due massicce fasce a lacunari e aperta da profonde lunette per ospitare le finestre.
Sotto l’altare si sviluppa lo scurolo, in forma di chiesetta a tre navi, con lapidi e monumenti funerari rimossi dall’aula superiore.
La cupola che sovrasta il presbiterio è affrescata. S’innesta su pennacchi retti da pilastri a fascio con capitelli ionici decorati con teste di angeli.
Il tamburo è alleggerito da quattro finestre intervallate da quattro nicchie con statue di angeli.
È illuminata dalla lanterna centrale.
Ai lati del presbiterio si aprono due monumentali cantorie contrapposte, con organi di Pietro Pirovano.
Il coro ottocentesco è impostato su una campata voltata a crociera e finisce in un’abside poligonale coperta da una semicupola.
Contribuiscono alla suggestione dell’ambiente interno i chiaroscuri generati dalla successione di altorilievi e bassorilievi, figurativi o decorativi, distribuiti tra le serliane, su pilastri e colonne, nelle cantorie degli organi, sulla cupola, nelle tribune contrapposte del coro, sui pennacchi della cupola, ripresi sugli altari laterali, dove “statue d’angeli gesticolanti” accompagnano le pale d’altare, e culminanti nella prima cappella a sinistra, dedicata alla Maddalena, dove un gruppo di Carlo Simonetta ritrae “la santa nell’atto di ricevere le Sacre Particole per le mani di due angeli” (Bascapè-Mezzanotte).
La chiesa è sede della cappellania per i fedeli di lingua polacca.

Nei dintorni




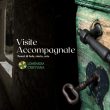
 Milano
Milano




